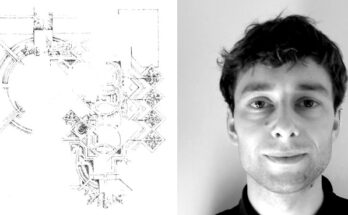Dei Twelve Thousand Days, Martyn Bates (Eyeless In Gaza) e Alan Trench (fondatore della World Serpent e attivo come Orchis e Temple Music), si erano perse le tracce da più di un decennio: dopo tre album fra il 2000 e il 2006 il lungo silenzio faceva presumere la fine del sodalizio, con ciascuno dei due impegnato nei rispettivi progetti. Invece, pochi mesi fa, fulmineo, l’annuncio di un nuovo lavoro in uscita per Final Muzik e i vecchi dischi che tornano a girare nel lettore per ingannare l’attesa. Per Bates, La cui vocalità inconfondibile marca a fuoco ogni brano, Twelve Thousand Days ha fin dall’inizio significato dar voce al lato più esoterico della propria poetica attraverso una musica che mantiene forti legami con la tradizione inglese, vicina per sensibilità ai capitoli della discografia di Tony Wakeford/Sol Invictus meno legati al neo-folk. Eppure nelle tracce di Insect Silence si nota subito qualcosa di insolito, una diversa vibrazione che fa apparire la possibilità di trovare nel disco qualche nuova perla (questo avevo sempre chiesto e ottenuto dagli ultimi lavori del musicista inglese) assolutamente secondaria. I primi brani del disco, folk di base, sono attraversati da un’elettricità inquieta che a volte resta sotto traccia – come nella poesia notturna di Invoke Hecate – altre erompe negli assoli fortemente espressivi di Death Went Fishing e Mad As The Mist (bellissima!) che chiama a raccolta gli spiriti magni di Omero, Orazio, Platone e Cicerone musicando una lirica dell’amato Yates (ben tre i suoi componimenti in scaletta): le porte fra i mondi sono aperte e non ci resta che attraversarle. La danza antica di Old Ladies As Birds e il folk poetico e sentito di Errant Desires ci dicono qualcosa della nostra condizione (“We are errant desire of Angels / a breath of time, a moment’s pause”) prima di giungere al brano centrale dell’album: Pathless è un colosso di oltre un quarto d’ora che non ha bisogno della durata per impressionarci. Prima è la voce di Bates, aiutato a tratti da una femminile e supportata da chitarra acustica e ed elettronica pulsante, a condurci lungo un sentiero tortuoso e poco illuminato, poi, dopo un intermezzo in cui flauto e synth prendono il sopravvento disegnando volute sottilmente inquietanti, è la voce di lei (una non meglio precisata Lisa) a recitare versi che si sovrappongono in modo spettrale per poi tornare fugacemente alle melodie che caratterizzavano la prima parte del brano. È un po’ un ‘opera nell’opera ma la vena di Bates e Trench non si esaurisce qui: prima di arrivare alla fine sono da segnalare almeno l’inquieta A Coat, che musica un testo di Yeats col senso drammatico dei Current 93, l’oscuro simbolismo amoroso di Descent, che riecheggia lontanamente le collaborazioni di Bates con Mick Harris e Max Eastley e si chiude con un coro di voci spettrali e, ancora con parole di Yates, la beffarda Arrow; infine in Red And Golden Fire, il dissonante pezzo di chiusura, sembra che tutti gli strumenti impiegati nell’album vengano a darci commiato. Impossibile, con una recensione di qualche riga, rendere la ricchezza e la complessità di Insect Silence: è un disco che utilizza quanto fatto finora dai due come base di partenza ed evolve il suono, coeretemente ai testi, verso molteplici direzioni, con uno spirito di sperimentazione che, in più di un momento, mi ha ricordato quello dei primi Eyeless In Gaza. Verrebbe da chiedersi se ci sia ancora tempo, per dei musicisti non di primo pelo, di aprire una nuova fase creativa, ma importa veramente? Quello che conta è godersi, qui e ora, l’opera più interessante di tutta la discografia di Twelve Thousand Days.
Twelve Thousand Days – Insect Silence (Final Muzik, 2018)